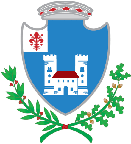In occasione del 2 giugno ospitiamo un testo di Daniele Pugliese, Presidente dell'associazione Tessere, dedicato alla madre scomparsa per Covid il 25 marzo 2020.
Di lì a poco avrei compiuto 14 anni, l’età in cui la legge permetteva di guidare un ciclomotore di 50 centimetri cubi. Oltre a quella cilindrata bisognava raggiungere i 16 anni per salire su un 125 e 18 per le moto ancora più grosse.
Abitavamo a quell’epoca in una strada nella periferia nord di Firenze che si chiama via Giovanni dei Marignolle: un appartamento in affitto non molto grande, tant’è che mio fratello Davide e io eravamo costretti a dormire in salotto tirando giù tutte le sere il divano letto.
Eravamo finiti lì perché qualche anno prima i miei genitori si erano separati definitivamente e mia madre, rimasta sola, non poteva più permettersi l’affitto della casa ai piedi di Fiesole dov’eravamo andati ad abitare quando nel 1961 lasciammo Torino per trasferirci a Firenze.
Qui mio padre, che si era da poco licenziato dalla casa editrice Einaudi, aveva trovato da lavorare alla casa editrice Sansoni e il suo stipendio, assommato a quello di mia madre che lavorava all’Istituto nazionale di previdenza sociale – l’inps, il primo baluardo del welfare state in Italia subito dopo la guerra, la Liberazione, la stesura di una Costituzione attenta ai lavoratori e alle fasce più deboli della società –, consentivano di vivere in una casa abbastanza borghese dove c’era una stanza per i miei genitori, una per noi figli, un salotto abbastanza grande, lo studio pieno di libri di mio padre.
Ma con la loro separazione le cose erano cambiate di molto. «Ti andrebbe di andare a vivere a Scandicci?» mi chiese mia madre dopo aver fatto due conti: pagando il mutuo per comprare un appartamento appena finito di costruire al secondo piano del n. 25 di via Ugo Foscolo, avrebbe speso poco di più di quanto pagavamo d’affitto nell’alloggio di Rifredi e alla fine la casa sarebbe rimasta di sua proprietà, senza nessuno che potesse cacciarla da lì.
Il fatto, però, era che Scandicci era molto più lontana dal centro di Firenze, dove andavo a scuola e dove viveva la maggior parte dei miei amici.
«Ad una condizione», risposi a mia madre dandole il mio assenso: che io potessi muovermi con il Ciao donato dai miei genitori a mio fratello Davide, che io ricomprai da lui a 70 mila lire perché nel frattempo a lui era stato regalato un Morini da fuori strada, 125 di cilindrata.
Mia madre comprese ed accettò il “ricatto”. La casa nuova, peraltro, era dotata di un piccolo vano al piano terreno dove potevo parcheggiare la notte il mio motorino e avevo tutti gli arnesi per ripararmelo da solo. Un po’ di cose le avevo imparate lavorando nell’estate del 1971, dopo essere stato bocciato in quarta ginnasio, dal carrozziere Falletta al Vingone. «Decidi tu – disse mia madre – o lavori, o studi».
La presi in parola e feci entrambe le cose. Durante la settimana studiavo e facevo politica nel movimento degli studenti e nei week end e nelle feste comandate mi travestivo da cameriere e andavo a servire ai tavoli di ristoranti e banchetti, raccattando quel tanto che mi bastava per pagarmi la miscela al 2% del Ciao.
Lasciai quella casa poco dopo aver compiuto vent’anni, quand’ero iscritto all’Università, ma soprattutto avevo iniziato a fare il lavoro che sognavo per la mia vita: il giornalista a “l’Unità”, lo stesso fatto dai miei genitori in gioventù. Lì ci sono rimasto per più di 25 anni.
Mio fratello se n’era già andato da tempo, prima a fare un po’ l’hippy e poi, messa la testa sulle spalle, il fotografo di moda che lo portò prima a Milano e poi a New York dove le sue foto uscivano su “Vogue”.
Io andavo avanti e indietro, 10 chilometri all’andata e 10 al ritorno, anche due volte al giorno, addirittura tre se uscivo pure dopo cena. Ma a Scandicci mi trovavo proprio bene.
Benché allora fosse solo un gran dormitorio di gente che rincasava dall’ufficio per ripartire la mattina successiva verso la stessa meta, l’aria che si respirava era assai più fresca, c’era un po’ di brezza anche durante l’estate, si sentiva che alle spalle c’erano le colline che salgono a Mosciano e a San Michele a Torri.
Mia madre, Cecilia Cima, in quella casa ci ha vissuto fino al 25 marzo dello scorso anno, quando, ormai 91 enne, è stata una delle prime vittime del Covid. Per fortuna non ha sofferto molto, ho potuto capire da quel che mi dicevano i medici di Torregalli, perché è passata da uno stato sereno in cui credeva di rimanere pochi giorni in ospedale a farsi passare una semplice influenza alla sedazione profonda con cui si allevia il dolore di chi è giunto alla fine.
Ma mi è sembrato doveroso segnalare al sindaco di Scandicci Sandro Fallani – che avevo conosciuto negli ultimi anni del mio lavoro da giornalista – che la città da lui amministrata aveva appena perso una cittadina degna di essere ricordata.
Mia madre, infatti, in gioventù è stata una staffetta partigiana che ha dovuto patire non solo la fame, ma anche l’impotenza quando i miliziani fascisti prelevarono suo padre affinché spifferasse dov’era andato a nascondersi in montagna suo figlio Bartolomeo, che tutti chiamavano Lino.
Lui, nato a Foglizzo Canavese il 25 agosto 1925, era il vice comandante della brigata garibaldina “Michelangelo Peroglio” attiva nella valle di Lanzo nei dintorni di Torino.
Lino e Cecilia erano i figli di Giovanni Cima e di Agnese Givogri, e avevano un’altra sorella, Angela, di qualche anno più grande di mia madre nata il 6 giugno 1929.
Proprio con la sorella Angela, dal giugno 1944 all’aprile 1945 mia madre prese parte come staffetta nelle formazioni partigiane, come testimoniano i lasciapassare del Comitato di Liberazione Nazionale che le consentivano di muoversi ai posti di blocco senza essere arrestata.
Quei fogli erano firmati da Giovanni Burlando che era il comandante di quella formazione impegnata a combattere i nazisti in un terreno di montagna che loro conoscevano bene, mentre i tedeschi no.
Le carte dell’epoca ancora rimaste, che mio fratello Davide e io abbiamo deciso di regalare all’Istituto storico della Resistenza di Torino, spiegavano che mia madre «aveva adibito la propria casa, in cui abitava, a luogo di ritrovo e smistamento di partigiani, tanto è vero che il capo-famiglia, fu arrestato per detta attività, e trattenuto in prigione per quindici giorni».
Inoltre, «dal giugno 1944 al giorno della smobilitazione accompagnava sbandati e giovani nelle formazioni partigiane, recapitando messaggi, medicinali e qualche volta fu adibita ad informatrice».
Di ciò mia madre non ne ha mai fatto vanto, ma renderle omaggio in questi tempi bui in cui c’è da avere di nuovo paura di svolte autoritarie nel Paese, appare a me doveroso e ringrazio il sindaco Fallani di darmene l’opportunità.
Finita la guerra mia madre si iscrisse al Partito comunista italiano, rinnovando ogni anno la tessera fino a quando, dopo la Bolognina, cambiò nome e imboccò altre strade non sempre coerenti con le origini da cui provengono.
La stima che aveva saputo creare intorno a sé la spinse ad accettare la richiesta di Mario Montagna, all’epoca direttore de “l’Unità”, di diventare la segretaria della redazione di Torino del giornale fondato nel 1924 da Antonio Gramsci. In redazione rimase indicativamente fra il 1954 e il 1957, quando nacqui io.
Mia madre, infatti, nel frattempo si era sposata con Orazio Pugliese, dal quale ebbe nel 1954 mio fratello Davide. Proprio per poter allevare due figli optò per un lavoro che la impegnasse soltanto mezza giornata e appunto chiese di essere assunta dall’appena nato Istituto nazionale per la previdenza sociale nel quale lavorò dal 16 luglio 1958 al 2 luglio 1992 quando andò in pensione.
Ha lasciato alcuni brevi scritti autobiografici con le memorie di quelle lontane stagioni.
Io sono orgoglioso che Scandicci la senta come una sua cittadina fedele e affezionata, perché questo è stata e la sua casa per tutto il tempo in cui ci ha vissuto è stata un punto di incontro di gente di tutte le età, di amici suoi e miei e di mio fratello Davide.
Certo, Cecilia Cima non era una scandiccese puro sangue, ma a questa città lentamente cresciuta fino a diventare uno dei posti più ambiti dove vivere nei dintorni di Firenze è stata intimamente legata.
Con mio fratello Davide, com’era scritto nelle sue volontà, abbiamo disperso le sue ceneri sulla vetta del Monte Bianco, dove da giovane andava a “rocciare” con i suoi amici e compagni.
Nel cimitero di Scandicci però riposano molti suoi amici, a cominciare da Giorgio Jorio e da Gioia Ciotti che per lungo tempo hanno fatto della loro casa a Mosciano il punto d’incontro di generazioni molto diverse tra loro, legate però dall’amore per la pace e la democrazia.
Sarebbe bello che sulle mura esterne della sua casa in via Ugo Foscolo al 25 potesse essere affissa una piccola targa d’ottone che la ricordi. Perché Scandicci ha avuto fortuna ad avere Cecilia Cima tra i suoi cittadini, come lei ha avuto fortuna ad abitare in un Comune così bello.
Daniele Pugliese